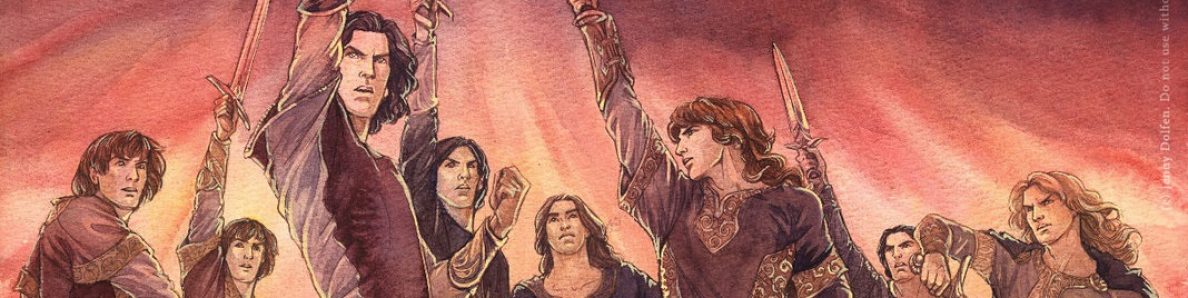[Edit maggio 2021: abbiamo corretto un errore su Carmelo/Calvario dovuto alla nosta ignoranza. Segnaliamo inoltre che sono usciti i Quaderni di Arda con gli atti del Convegno di Trento. Almeno parte degli interventi, fra cui quello di Fatica, si trova sul sito I Quaderni di Arda.]
Dopo una settimana in cui abbiamo detto addio a vita, lavoro e sonno (amici e familiari non ne abbiamo), avendo radunato appunti e ricordi, diamo alfine seguito al precedente post scritto a caldo, in cui abbiamo saltato un paio di passaggi. Come al solito Giuseppe Scattolini ci ha battuti. Quasi contemporaneamente al nostro articolo è uscito anche il resoconto di AIST, in cui viene corretto l’errore su Old Gerontius, e di Cercatori di Atlantide, che si dilunga sulle domande più di quanto non siamo riusciti a fare noi.
Confermiamo che non solo Luca Manini, ma tutti gli altri relatori di Trento sono stati graditissimi, e molto più efficaci di Fatica. Forse anche per scelte tecniche e organizzative; ma questo è un problema complesso che rimandiamo a un futuro post (forse). Abbiamo ironizzato sul “Fallire sempre meglio” soltanto in relazione all’intervento di Fatica. Nella nostra esperienza, la traduzione di un testo è di rado un fallimento; piuttosto è una curva asintotica che idealmente si avvicina sempre più alla linea retta (l’originale) senza mai raggiungerla, all’infinito.
E’ stato confermato che gli atti del convegno verranno pubblicati a marzo sul n. 2 dei Quaderni di Arda. Nel frattempo, la Voce di Arda sta organizzando una puntata speciale per sabato 12 dicembre alle 16:30, con i traduttori e studiosi Gianluca Comastri, Costanza Bonelli, Enrico Spadaro, Francesca Montemagno e Paola Cartoceti.
Il titolo dell’intervento di Fatica era: Fidarsi del racconto: ritradurre Il Signore degli Anelli. Fatica aveva a disposizione circa 35 minuti, più una ventina per le domande. Ha speso un quarto d’ora per trattare l’accoglienza critica al SdA, delineando la situazione italiana e citando critici anglofoni quali WH Auden, Edmund Wilson e Harold Bloom. E già qui ci sarebbe stata materia per una conferenza di un’ora; possibilmente da parte di un oratore più eloquente. Fatica, pur avendo davanti un testo, ha parlato spesso a raffica, lasciando cadere senza enfasi nomi e riferimenti difficili da cogliere, a differenza di tutti gli altri relatori, perfino quelli anglofoni. E’ stato un intervento per nulla divulgativo, privo di slides esplicative che quasi tutti gli altri hanno utilizzato. Soprattutto il fatto di essere costretti ad aspettare marzo per ripassare i concetti ha influito molto sulla fruibilità dell’esperienza.
Sembra comunque di ricavarne la lezioncina che Tolkien non è perfetto, anzi, e che è assurdo difenderlo in toto per criticare la nuova traduzione. Insomma, Fatica ha spostato le sue critiche da Alliata a Tolkien stesso. Proprio ieri su FB l’articolo di Giuseppe è stato seguito da una serie di commenti da parte di atei, cattolici, marxisti, conservatori e chi più ne ha più ne metta, uniti da ciò che ciascuno trova di bello in Tolkien, disposti a collaborare fra loro. Nessuno di noi affronta Tolkien “con i paraocchi”.
In quel quarto d’ora Fatica ha anche strizzato, senza possibilità di contraddittorio, considerazioni sui mondi secondari e sulla poetica di Tolkien che pure avrebbero meritato ben più spazio. Non siamo sicuri di concordare sul fatto che Gandalf sia per Tolkien solo un personaggio strumentale alla trama, che i mondi secondari siano in antitesi al mondo primario, o che non sia possibile trovare in un libro una Verità personale da cui trarre ispirazione e conforto.
Sembra di intendere che bisogna “fidarsi del racconto” e non di Tolkien, bravo stilista (niente facili ironie: significa “colui che lavora sullo stile”, in qualsiasi campo) che imbroglia il lettore con giochi di parole, stilemi strani e l’insistere su una Provvidenza sottesa alla storia, quando invece sarebbe solo un’avventura da leggere senza farsi troppi problemi. Addirittura Fatica dà torto a Tolkien sull’allegoria: non importa che lo scrittore dichiari nella Prefazione del suo libro “I cordially dislike allegory in all its manifestations… I think that many confuse ‘applicability’ with ‘allegory’.” Per Fatica, una lettura allegorica potrebbe “aprire scorci inediti”.
Potremmo non aver capito nulla, anche perché non siamo critici letterari o teologi. Però abbiamo sempre sostenuto, anche andando contro l’opinione di Alliata (si veda la nostra pagina “Premesse errate”), che nel TESTO – originale o tradotto da chicchessia – non c’è nulla di ideologico; l’ideologia è quella che sta dietro a tutta l’operazione Fatica. Questa è la prima volta che il traduttore, con l’avallo dell’AIST, dà un’interpretazione ideologica del TESTO, che sarebbe perfettamente legittima come opinione sua (grazie all’applicabilità) ma che è stata presentata come unica interpretazione possibile.
LINGUA E TRADUZIONE
Quando finalmente Fatica affronta questi argomenti, lo fa affermando che il SdA è la traduzione di un libro scritto in lingua hobbit. Fatto importantissimo e sostanzialmente vero, ma compresso e impreciso, e privo della specificazione “in inglese moderno”. Invece di continuare a ribadire il concetto con il tutto maiuscolo come abbiamo fatto in passato, vediamo cosa dice esattamente Tolkien nell’Appendice F, capitolo II:
In presenting the matter of the Red Book, as a history for people of today to read, the whole of the linguistic setting has been translated as far as possible into terms of our own times. Only the languages alien to the Common Speech have been left in their original form; but these appear mainly in the names of persons and places. The Common Speech, as the language of the Hobbits and their narratives, has inevitably been turned into modern English.
Questo è il nucleo da cui partire per qualsiasi discussione traduttiva su Tolkien.
Vediamo la versione Fatica, non per criticare ma per aiutare i nostri lettori poco pratici dell’inglese:
Nel presentare la materia del Libro Rosso come una storia da far leggere ai contemporanei, l’intero impianto linguistico è stato tradotto nei limiti del possibile in termini attuali. Soltanto le lingue diverse dalla Lingua Comune sono state lasciate nella forma originale; ma più che altro sono presenti nei nomi di luoghi e di persone. La Lingua Comune, quella degli Hobbit e dei loro racconti, è stata inevitabilmente trasposta nell’inglese moderno.
Allora: si suppone che Fatica abbia tradotto questo passo. Come ha fatto a dimenticarsene? Perché nessuno dei suoi collaboratori glielo ha mai ricordato? Perché sia lui che loro accantonano con tanta disinvoltura i concetti di contemporanei, termini attuali, inglese moderno?
Ce lo chiediamo perché gran parte dell’intervento è stata occupata dalla condanna feroce dei presunti anacronismi di Tolkien, pressoché identica a quella di Parma, Modena, Torino (si veda la nostra pagina “Ottavio Fatica”). Ma Tolkien scrive in inglese moderno, e va tradotto in italiano moderno. Fatta salva ovviamente la resa del suo stile invero particolarissimo tramite figure di suono e arcaismi appropriati, di cui abbiamo già parlato – non senza lodi – riguardo alla Lettera 171.
Fatica fa una carrellata piuttosto confusa sugli anacronismi. Solo di rado specifica che sta parlando di termini usati da Tolkien: li mescola alle scelte dell’innominata Alliata e affastella le motivazioni, che siano meramente cronologiche oppure concettuali (quindi tecnicamente non si tratterebbe di anacronismi). Cerchiamo di mettere ordine:
Traduzione Alliata/Bompiani:
Non troviamo una contraddizione cronologica in termini relativamente recenti ma diffusi nell’italiano corrente come panorama, pony, ciao (usato 6 volte da Fatica nel volume revisionato), battezzare, inconsciamente, valigie, matite. La picchiata la fanno i rapaci da molto prima degli aerei. Ci stupisce l’obiezione a scacco (se abbiamo capito bene l’ostica dizione di Fatica), riferimento a un gioco diffusosi in Europa prima dell’anno 1000, di cui poteva benissimo esistere una controparte nella Terra di Mezzo; così come lo springlering ricorda i balli scatenati del Calendimaggio.
Potremmo al massimo condividere la perplessità per modi di dire come in fila indiana, fuoco di fila e soprattutto come un treno espresso, ma non ricordiamo di aver avuto un soprassalto leggendoli, poiché sono parte del linguaggio corrente e passano inosservati. Farli notare è importante, e correggerli avvicina quella famosa curva asintotica un poco di più alla linea retta; ma non invalidano la traduzione A/B.
Originale Tolkien:
- Anacronismi cronologici
Fatica critica una serie di termini usati da Tolkien, che secondo lui non esisterebbero nella Terra di Mezzo perché propri di culture antiche del nostro mondo. Gli sfugge il fatto che l’inglese moderno, come l’italiano moderno, ha assorbito termini e modi di dire che hanno quasi perso il loro significato originale. Con questo criterio, scrivendo un racconto fantastico bisognerebbe buttar via il dizionario. Togliamo il latino e il greco dall’italiano, e non resta quasi niente.
Lo stesso vale per i francesismi nell’inglese, e Fatica sembra ammetterlo, ma li confonde con la lingua francese in generale, dicendo che Tolkien non amava le parole francesi. Tolkien scrive nella Lettera 213:
For instance I dislike French, and prefer Spanish to Italian – but the relation of these facts to my taste in languages (which is obviously a large ingredient in The Lord of the Rings) would take a long time to unravel, and leave you liking (or disliking) the names and bits of language in my books, just as before.
Tolkien si sente liberissimo di usare comuni parole inglesi di origine francese. Fatica gli contesta Bruinen (il fiume Loudwater, Rombirivo in traduzione A/B) perché deriverebbe dal francese bruit, rumore, e prima dal latino bruire. Non è menzionato nella Nomenclatura; ma anche se l’origine fosse quella, è una bella onomatopea che non si capisce perché vada condannata.
Altri esempi: phalanx (“falange”, dal greco, riferito a uno stormo di cigni; anche Fatica lo usa due volte nel volume revisionato), mementoes (dal latino, che Fatica, contraddicendosi, traduce come souvenir anziché “ricordi” o analoga parola italiana), jovial (dal latino tramite il francese, riferimento a “un improbabile Giove” a cui pochi inglesi, francesi o italiani probabilmente pensano usando questo termine).
A questa categoria appartiene un clamoroso errore che Fatica continua a ripetere (Modena 2020) e che non viene MAI corretto dai suoi collaboratori [fino ad ora, vedi sopra]. Old Gerontius viene definito da Fatica “un tripudio di incongruenza”, perché Gerontius viene dal greco e significa già “vecchio”. Con questo criterio, un racconto fantastico non potrebbe menzionare un bambino chiamandolo “il piccolo Paolo” perché Paolo significa già “piccolo”. Ma soprattutto, GERONTIUS NON E’ IL BISNONNO DI BARBALBERO, E’ IL VECCHIO TOOK:
‘Yes, it is all very dim, and stuffy, in here,’ said Pippin. ‘It reminds me, somehow, of the old room in the Great Place of the Tooks […] They say the Old Took lived in it year after year, while he and the room got older and shabbier together – and it has never changed since he died, a century ago. And Old Gerontius was my great-great-grandfather…”
- Anacronismi concettuali
Jovial ci porta a un’altra serie di obiezioni da parte di Fatica, che riguardano il presunto “abuso” di termini mitologici e religiosi. Contestando dryad (“la nota più stridente del libro”) ed espressioni come devils, devilry, hell-hawks, Lor’ bless you, il Fatica lettore del Silmarillion ignora l’immanenza degli Ainur nella Terra di Mezzo: spiriti angelici buoni oppure corrotti, come Gandalf e Saruman, o il Balrog o lo stesso Sauron, o creature come Baccador, la Figlia del Fiume, assimilabile a una driade. Questa immanenza, discendente da Eru e ben spiegata nel Silmarillion, Fatica la liquida come “animismo“. Le invocazioni/preghiere a Varda Elbereth e la scena in cui Faramir e compagni si volgono verso Ovest prima di mangiare per un breve momento di riflessione, aggiunte al racconto della Creazione nel Silmarillion, rendono evidente che la Terra di Mezzo possiede un sistema religioso, anche se quasi mai esplicito. Chi può escludere con certezza che Sam, esclamando Lor’ bless you, si riferisca a Eru?
Babel rientra nelle succitate espressioni diventate modo di dire corrente. Ma criticando l’espressione ancient of days, Fatica commette prima di tutto un errore testuale: non lo dice Aragorn ma il narratore.
But when Aragorn arose all that beheld him gazed in silence, for it seemed to them that he was revealed to them now for the first time. Tall as the sea-kings of old, he stood above all that were near; ancient of days he seemed and yet in the flower of manhood; and wisdom sat upon his brow, and strength and healing were in his hands, and a light was about him.
Inoltre ancora una volta Fatica ignora il contesto della frase e il lettore a cui si rivolge. Secondo lui la prima cosa a cui fa pensare è l’illustrazione di William Blake, che “conoscono tutti”; e inoltre si trova nel Libro di Daniele (che, si suppone, pure conoscono tutti). Ma l’espressione di Daniele viene tradotta come Antico DEI Giorni, con le maiuscole; invece ancient of days senza maiuscole significa letteralmente “carico d’anni” e in inglese è una costruzione identica a “bello di fama e di sventura”. Se dobbiamo “fidarci del racconto”, nulla nel SdA autorizza a pensare che in questa scena Aragorn venga paragonato a Dio. Ah, ma Tolkien imbroglia e si contraddice, è ovvio.
Infine, l’ANIMA. Come già affermato a Torino 2020, Fatica ribadisce che “non sembra un concetto compatibile con quel mondo, almeno non come Tolkien lo aveva concepito inizialmente”. Non ci risulta che Tolkien abbia MAI negato il concetto di anima nella Terra di Mezzo. La domanda posta a Fatica dopo il suo intervento, ottima dal punto di vista strategico, conteneva forse un errore tattico, perché neanche il moderatore l’ha capita: invece di chiedere se Fatica conosce il significato di fëa e hroa, sarebbe forse bastato chiedere di Fëanor. Il lettore del Silmarillion non può ignorare quale splendida e nefasta influenza abbia il significato del suo nome nella storia della Terra di Mezzo.
- Non anacronismi
Sparsi a caso nella tirata di Fatica ci sono termini ed espressioni che solo Tolkien usa, o che usa in accezioni insolite: prerogativa di qualsiasi scrittore. Fra i francesismi inaccettabili, Fatica nomina nail-knife perché era un’arma usata dai soldati francesi nella I guerra mondiale, detta clous (non clou come nell’articolo AIST su Modena 2020: finalmente abbiamo capito il riferimento) e ottenuta da una baionetta. Si impara sempre qualcosa; ma si scopre anche che nail-knife è anche un termine moderno per i coltelli di emergenza da campeggio o da survival, ottenuti da chiodi o barre di ferro: esistono addirittura tutorial per realizzarli. Poiché nel contesto del libro (ancora) si tratta di un’arma posseduta da Faramir, è legittimo immaginare che i Raminghi dell’Ithilien si armino come possono, anche senza usare baionette francesi.
Nightshade, già discusso da noi qui e qui, per Fatica è “l’apice”. Non possiamo verificare se davvero nessuno scrittore anglofono l’abbia mai usata come “oscurità”: però leggendo As nightshade was closing about them Aragorn halted non ci si immagina piante di belladonna che improvvisamente spuntano tutto attorno. La scelta del termine è particolare, ma il lettore capisce di che si tratta dal contesto.
Fatica ne ha anche per le virgolette di Tolkien (si veda Modena 2020). Secondo lui, ogni volta che nel discorso diretto si trovano parole fra virgolette, il lettore si immagina quel personaggio che fa il “lezioso gesto delle dita, vezzo tutto moderno.” Siamo spiazzati. Non gli passa per la mente che le virgolette sulla pagina scritta possono indicare un cambiamento di tono, un’espressione del viso, qualsiasi cosa che non siano le air quotes.
Senza soluzione di continuità, Fatica passa a discutere del gioco di parole Cotton-Gamgee, e a questo punto non si capisce più se stia criticando, ammirando, cercando di dimostrare qualcosa. Ne esce il ritratto di uno scrittore che bara, si caccia nei pasticci e deve “salvare capra e cavoli”, che ha inventato lingue prive di “corpo”, di “ricordi ancestrali, richiami affettivi, culturali e storici”. Esattamente il CONTRARIO di ciò che ha fatto Tolkien.
Ah, e non dimentichiamo che il SdA è un libro “asessuato”.
PARTE FINALE
- Kipling, Williams e la co-inerenza
Verso la fine, Fatica si lancia in una divagazione sulle possibili influenze in Tolkien di Kipling, che attraverso Charles Williams avrebbe ispirato agli Inklings il concetto di co-inerenza: un esempio è per i cristiani la partecipazione alla morte di Cristo sulla croce, teorizzata nelle Lettere di San Paolo. Ammettiamo di buon grado le nostre difficoltà nel seguire questo passo: conosciamo poco Kipling (più che altro come poeta) e ancor meno Williams. Anche da ignoranti, però, abbiamo notato due errori macroscopici:
1_ Williams e gli Inklings non hanno mai conosciuto Rob Gilson e GB Smith, i due amici di Tolkien morti durante la I guerra mondiale.
2_ Fatica paragona l’ascesa di Frodo al Monte Fato con la salita di Gesù al Monte CARMELO. De hoc satis.
[EDIT maggio 2021: uno dei nostri informatori, più colto di noi, ci ha segnalato “La Salita al Monte Carmelo” di S. Giovanni della Croce. E’ probabile che Fatica si riferisse a questo, quindi lo togliamo dagli errori.]
- Scelte traduttive
Nei 6-7 minuti finali, finalmente, Fatica parla delle sue scelte traduttive. Giustamente dichiara di aver tenuto conto, nella revisione del volume unico, delle critiche espresse dagli appassionati; ma si stupisce anche che nessun altro autore sia così sviscerato in Italia, nemmeno Beckett. Non si rende conto del fatto, da noi già espresso nel nostro post su Moby Dick, che nessun altro autore ha avuto in Italia (grazie anche alla traduzione A/B) un seguito così appassionato, che ha portato alla nascita dell’AIST stessa, della STI, di infinite altre realtà. Non ci risulta che in Italia esista l’Associazione Italiana Studi Beckettiani o la Società Beckettiana Italiana.
Fatica accenna alle correzioni da lui apportate (togliere maretta e chimera, termini perfettamente accettabili secondo il ragionamento sull’italiano corrente da noi delineato più sopra) e a quelle che gli sono sfuggite; rimpiange di non aver tolto anfitrione, che già noi abbiamo criticato, ma che sempre per gli stessi criteri è del tutto legittimo.
- Fell
Nella revisione, Fatica ha eliminato il suo fero, che almeno al lettore italiano poteva far pensare a fiero, feroce. Lo ha sostituito con fello, termine molto meno comprensibile in italiano corrente. Cita la dantesca “anima fella”, che ha inequivocabilmente un senso negativo. Treccani riporta due voci, fello e fellone, dal latino medioevale (quindi da eliminare secondo i criteri di Fatica stesso, come memento), con significato di “fellone, traditore, malvagio” e, solo anticamente, di “inferocito”. Fatica lo usa sempre in senso negativo, TRANNE che in un bellissimo passo che diventa oscenamente ridicolo, suggerendo che i Rohirrim sono un popolo di traditori (A/B almeno usa spietato):
These staves he spoke, yet he laughed as he said them. For once more lust of battle was on him; and he was still unscathed, and he was young, and he was king: the lord of a fell people. And lo! even as he laughed at despair he looked out again on the black ships, and he lifted up his sword to defy them.
La strofe recitò, ma rise egli nel dirla. Perché l’aveva di nuovo preso la bramosia di battersi; ed era ancora illeso, ed era giovane, ed era re: sovrano di un fello popolo. Ed ecco che, mentre rideva della disperazione, tornò a guardar le nere navi e, con gesto di sfida, alta levò la spada.
Ancora: Fatica critica la frase di Tolkien “outrunning the wind in its fell speed. / They fell forward…” suggerendo che forse per distrazione Tolkien ha usato i due significati di fell, e che se un anglofono trova fell automaticamente pensa al passato di fall. Non vorremmo confondere ulteriormente le idee a Fatica, ma da lettori di James Herriot sappiamo che fell è anche un regionalismo per “altura, collina scoscesa”. Oseremmo dire che in genere gli anglofoni sanno distinguere fra i diversi significati di una loro parola. [Ci segnalano anche to fell = abbattere (alberi)]
- Nomi
Fatica rimpiange di essere stato troppo prudente lasciando intatti nomi quali Baggins, tradotti in tutte le altre lingue. Gli è venuto in mente troppo tardi Falcante. Non vogliamo entrare nella questione perché qui si tratta di gusti, ma ci teniamo volentieri Frodo Baggins che ormai è entrato nell’immaginario collettivo. Non ricordiamo bene, ma da qualche parte abbiamo forse contestato il fatto che Strider sarebbe anche il nome del cavallo di Frodo. Ci sbagliavamo, è proprio così; solo che noi cercavamo “pony” e non “cavallo”.
- Poesie
Fatica non ne ha parlato in questo punto preciso, ma per amor dell’ordine inseriamo qui l’argomento: a quanto pare, la versificazione di Tolkien è “vecchio stile”, con “temi desueti”. Come nella Canzone di Bilbo, supponiamo, che parla di nostalgia, vecchiaia, morte.
Fatica giustifica inoltre le proprie scelte nel tradurre le poesie citando un esempio, perirono pugnando in paese alieno, tradotto “nel modo e nel senso dello spirito dello scrittore”. Il senso c’è, il modo non tanto: l’originale è fought and fell there in a far country. E’ la metrica anglosassone, che Fatica rispetta, ma il lessico non è quello di Tolkien: ogni singola parola è in uso nell’inglese corrente. Da totali ignoranti di metrica, avremmo piuttosto cercato una soluzione simile a caddero combattendo in lontana contrada, che è italiano corrente e non fa pensare alla superficie di Marte.
- Versi nascosti nella prosa
Come sopra. Fatica ha ragione a evidenziare questa caratteristica, che davvero sfugge ai più. Ha un po’ meno ragione quando gira il discorso in una frecciata contro molti studiosi che lo criticano: “Chi si vanta di averlo letto in inglese non può avere la sensibilità innata o acquisita che spesso non ha neppure il madrelingua, né la competenza che richiede studi e approfondimenti per apprezzare adeguatamente l’uso alquanto peculiare dello strumento.”
DOMANDE SIGNIFICATIVE
- Cosa significano fëa e hroa? Immortale risposta: “Mi bocciassero”.
- Moderatore: Se Tolkien scrive in inglese contemporaneo, in merito all’Ovestron, gli anacronismi sarebbero legata a questo… no, non si capisce, passiamo ad altro.
- Costanza (super-riassunta, ci vorrà un post dedicato o ne parlerà lei in radio il 12 dicembre): A che tipo di lettore si rivolge? Il testo originale è leggibile dai 17-18 anni, la traduzione costringe a uscire dalla storia e consultare il dizionario, esempio matricina [il comunissimo sapling, FdF]. Fatica: Non è vero che Tolkien è leggibile… So capire se un testo è difficile o no. A 17-18 anni si può leggere anche la mia traduzione. Per leggere Tolkien si va a vedere il dizionario spesso e volentieri. Tolkien è come Joyce, ci sono 3 volumi di lessici che crescono continuamente…
(Questi 3 volumi di lessici non riusciamo a individuarli. Conosciamo Uncommon Words di Tolkien Gateway e Old and rare words di The Encyclopedia of Arda, citati anche da Fatica a Torino 2020; ma questi lessici contengono termini presi da TUTTE le opere di Tolkien, compresi Silmarillion, HoME, le Avventure di Tom Bombadil etc; non solo dal SdA. Inoltre una buona parte dei termini è intuibile dal contesto, e spesso più facile per i lettori italiani, come argent, conclave, damask…)
ERRORI
Non terremmo fede alla nostra reputazione di bastardi se non concludessimo con un breve riassunto degli errori fattuali pronunciati da Fatica, spesso per la seconda o terza volta, e [spesso] non corretti da AIST:
Old Gerontius non è il bisnonno di Barbalbero
- Non è Aragorn che pronuncia la frase ancient of days
- Gli Inklings non conoscevano Gilson e Smith
Gesù è salito al Calvario, non al Carmelo.
Potremmo aggiungere gli errori già rilevati nel commento a Modena 2020 (Eowyn = Corinna?), ma si andrebbe troppo per le lunghe; e questa volta sappiamo per certo che Fatica aveva davanti un testo scritto, il che aggrava la situazione.